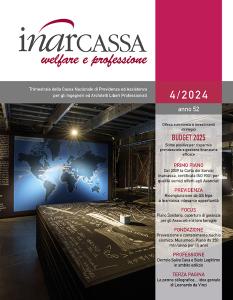Progettazione e conservazione attiva degli spazi aperti archeologici
In copertina: Madinah Piazza Shading Project, SL Rasch GmbH Special & Lightweight Structures. Modello di studio dell’ombreggiatura della piazza. MAXXI - Architettura instabile
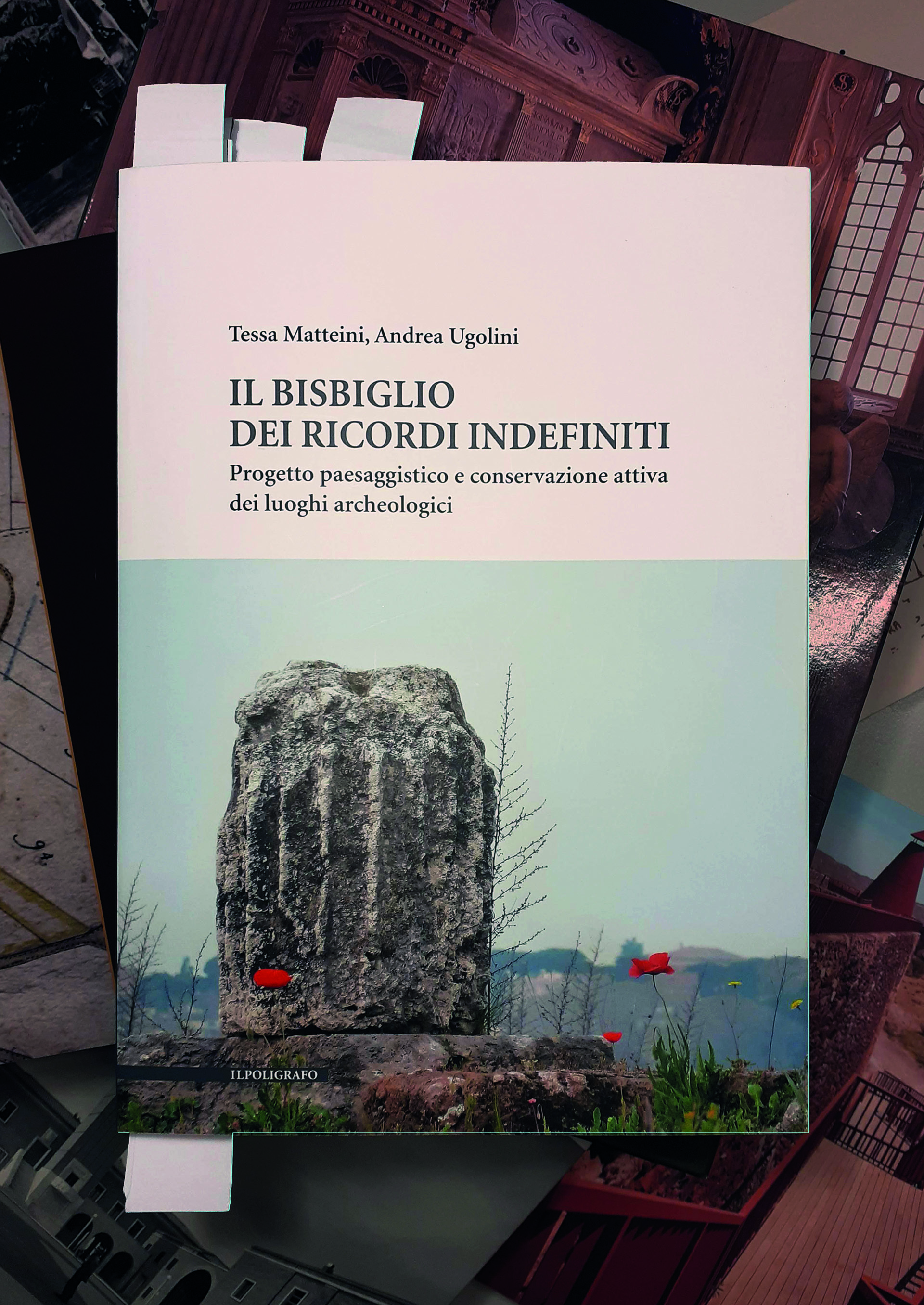
di M. Sirotti
La contemplazione di antichi ruderi che affiorano tra la vegetazione della campagna nella placida luce del tramonto.
Questa rappresentazione romantica del rapporto tra archeologia e paesaggio, tramandata fino a noi dai pittori del passato, influenza tuttora il nostro immaginario. Ben diversa, più articolata e complessa, è la realtà che gli architetti Tessa Matteini e Andrea Ugolini descrivono nel volume “IL BISBIGLIO DEI RICORDI INDEFINITI – Progetto paesaggistico e conservazione attiva dei luoghi archeologici”, pubblicato di recente dalla casa editrice Il Poligrafo. Entrambi docenti universitari, gli autori, che collaborano da anni confrontandosi sulle complesse questioni relative al rapporto tra conservazione dei manufatti archeologici e paesaggio, presentano qui il loro percorso di ricerca verso la creazione di una nuova base culturale e scientifica per la progettazione e la conservazione attiva degli spazi aperti archeologici. Un percorso che li ha condotti a tracciare le linee di un approccio innovativo a queste problematiche, frutto della combinazione delle loro specifiche competenze in architettura del paesaggio e in conservazione del patrimonio archeologico, facendo tesoro dei rispettivi strumenti e immaginari progettuali per creare una condivisione di idee che supera la separazione tra queste due discipline.
Non è quindi casuale che il loro volume si apra con le presentazioni di un architetto e di un’archeologa. Luigi Marino, che tanto ha contribuito alla definizione di strategie e pratiche di restauro archeologico, e Silvia Guidieri, responsabile delle politiche culturali del parco archeologico di Baratti Populonia. Ho trovato questo libro particolarmente interessante, anche per il ricco corredo di immagini che accompagna il testo, per cui ho approfittato di un recente incontro col professor Andrea Ugolini per invitarlo ad illustrare ai lettori della nostra testata gli argomenti trattati insieme alla sua collega, Tessa Matteini, e così abbiamo iniziato a conversare.
Professor Ugolini, lei è architetto e docente di restauro ormai da diversi anni e so che già all’inizio della sua attività professionale ha partecipato a campagne di scavo anche in luoghi lontani, come il Medio Oriente. Non mi stupisce quindi l’impegno profuso nella scrittura di questo volume che testimonia il suo profondo interesse per la conservazione dei luoghi archeologici. Mi ha però subito incuriosito il titolo e, in particolare, l’uso del termine “bisbiglio”, vuole spiegarne il significato?
“Il bisbiglio dei ricordi indefiniti” proviene da una frase scritta dall’architetto e archeologo Giacomo Boni nel 1913 sul Bollettino d’arte, nella quale il termine “bisbiglio” si riferisce a quell’armonica complessità che la natura e il tempo lasciano sulle rovine antiche. Armonica complessità che un intervento di restauro sul manufatto in rovina non deve cancellare.
Boni fu, infatti, tra i primi a intendere il restauro come “opera medica, non chirurgica”, da svolgersi sulla base di una conoscenza profonda non solo del manufatto su cui si va ad intervenire, ma dell’intero contesto circostante. Cura dei luoghi da svolgersi con perseverante attenzione, nella consapevolezza della loro fragilità e dell’intima relazione tra i manufatti e la natura. Seguendo il sentiero tracciato da Boni abbiamo pensato a questo libro, con l’intento di indicare un percorso utile a coloro che sono chiamati ad operare in queste realtà: archeologi, architetti, paesaggisti, restauratori...

Platino. Foto di A. Ugolini
Addentriamoci, allora, in questo vostro percorso lungo il sentiero tracciato da Giacomo Boni. Secondo voi, quali particolari attenzioni si dovrebbero tenere presenti se siamo chiamati ad intervenire in un luogo archeologico?
L’intervento dovrebbe partire dalla comprensione del lungo processo storico e ambientale che ha portato il luogo al suo stato attuale.
È importante conoscere le storie dei luoghi, stimolare la scoperta delle identità culturali locali. Dobbiamo promuovere un approccio progettuale che comporti una capacità di apprendimento continuo e includa un atteggiamento etico. È necessario accrescere le conoscenze e costituire la base per laboratori di storia aperti, in costante aggiornamento con l’avanzare delle ricerche e delle indagini. Tutto questo sulla base dei dati reali, seppur talvolta frammentari, forniti dalle indagini conoscitive, preventive e in corso d’opera, e sulle relazioni che il luogo intesse col paesaggio circostante. La necessità di basare l’intervento su tali elementi emerge chiaramente dal fatto che essi possono anche portare a nuove interpretazioni storiche. I fenomeni che analizziamo possono essersi evoluti gradatamente nel tempo fino a stabilizzarsi e divenire prevedibili, oppure, al contrario, possono essersi originati a seguito di cambiamenti improvvisi che innescano evoluzioni repentine. Come nel caso dei sempre più frequenti eventi naturali estremi, i cui effetti sono spesso amplificati dalle politiche di eccessivo sfruttamento del territorio. Il rapporto tra Costruito e Natura è, infatti, sicuramente uno dei temi più complessi, in particolare quando le dinamiche naturali si intrecciano con quelle dei manufatti allo stato di ruderi. Si crea allora un legame inscindibile e un’integrazione coi luoghi che richiede la consapevolezza della loro fragilità in relazione con una natura mutevole.
Proprio per questo il progetto paesaggistico e la conservazione attiva dei luoghi archeologici divengono un’incredibile opportunità. Preservare ciò che resta delle architetture antiche e delle tracce del passato, riattivare le loro relazioni con il paesaggio, porre attenzione alle dinamiche ecologiche, alla gestione della componente vegetale, al controllo delle acque, definire i margini del sito.
In effetti, il quadro che ha appena descritto è molto articolato e complesso e richiede quindi la compartecipazione di diversi attori. Quale approccio progettuale promuovete nel vostro volume e come dovrebbero interagire gli specialisti chiamati ad intervenire in un luogo archeologico?
Per affrontare la complessità di questi contesti occorrerebbero una visione progettuale comune e strategie di intervento che tengano conto della tutela materiale ed anche della ricostruzione delle trame storiche e culturali che legano i luoghi archeologici al loro contesto naturale e sociale. La complessità del dialogo tra le rovine e il paesaggio comprende non solo una dimensione fisica, ma anche storica, semantica ed ecologica, e il progetto del paesaggio archeologico non deve semplicisticamente ridursi al binomio rovine/vegetazione. È necessaria un’azione interdisciplinare nella quale sia possibile far convergere con efficacia e reciproco rispetto le diverse competenze e abilità, evitando conflitti tra i punti di vista parziali dei diversi operatori o il sopravvento di uno di essi.
Da qui la volontà di fornire a restauratori, architetti, paesaggisti e archeologi, nuove strategie condivise per la salvaguardia degli spazi aperti archeologici. Per questo pensiamo sia necessario promuovere la riattivazione delle connessioni storiche, ecologiche e culturali che caratterizzano tali spazi e attuare programmi definiti di gestione e di manutenzione volti a garantirne la continuità e la trasmissione futura.



Quando parla di riduzione semplicistica del paesaggio archeologico al binomio rovine/ vegetazione forse si riferisce anche alla rappresentazione che ne hanno dato tanti pittori del passato, soprattutto dell’epoca del Romanticismo, contribuendo così a creare quel gusto del pittoresco che tutti conosciamo. A me vengono subito in mente le vedute con rovine di Francesco Guardi o di Caspar David Friedrich. Oppure i disegni e i dipinti dei pittori che hanno accompagnato Goethe e i tanti viaggiatori del Grand Tour con l’incarico di fissare in un’immagine il ricordo dei luoghi visitati. Ho visto che nel vostro volume trattate anche questo aspetto della lettura del paesaggio archeologico, cosa può dire a tale proposito?
Va riconosciuto che il legame tra arte figurativa e paesaggio archeologico ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione di una consapevolezza culturale dei suoi valori. Dai paesaggi con rovine della scuola del Grand Tour fino alle rovine industriali di Robert Smithson e alle fotografie di Bernd e Hilla Becher, il ruinismo pittorico ha influenzato l’immaginario di questi luoghi. Avviene così che la categoria del “picturesque” di derivazione ruskiniana viene facilmente confusa con la complessità dell’integrazione storica, semantica ed ecologica dei luoghi delle archeologie. Oltre a questo, anche il giardino archeologico ha trovato una sua espressione letteraria e architettonica già a partire dal Quattrocento, con esempi come il tempietto di Bramante a Gennazzano e il Sacro Bosco di Bomarzo. È poi importante sottolineare come, nel Settecento, la cultura del parco paesaggistico e le rovine artificiali abbiano concretamente contribuito alla definizione di un dialogo progettuale tra l’uomo e il passato.
Pensando alla componente naturale del binomio rovine/vegetazione, mi figuro, da un lato, piante che contribuiscono con la loro presenza a delineare il carattere di un determinato paesaggio e, dall’altra, vegetali che crescono sulle rovine stesse accelerandone il disfacimento. Come si è intrecciata l’evoluzione dello studio degli aspetti botanici connessi ai siti archeologici con la formazione di una vera e propria cultura del restauro?
Sino dall’Ottocento la ricerca botanica ha approfondito la conoscenza della flora presente in questi siti, a iniziare dallo studio del Colosseo da parte di Richard Deakin nel 1855, che segnò un passo importante nella catalogazione delle piante in contesti archeologici. È però nella seconda metà del Novecento, con la nascita della Landscape Archaeology, che l’attenzione degli studiosi si concentra sul paesaggio antico, costituito non solo da ‘monumenti’, ma inteso come prodotto di una serie di situazioni storiche determinate dalle azioni umane. Oggi la ricerca botanica è progredita fino a giungere alla definizione dell’indice di pericolosità proposto da Maria Adele Signorini nel 1996, uno strumento molto utile anche dal punto di vista operativo.


Tornando nuovamente all’approccio multidisciplinare di cui nel vostro volume sostenete la necessità, cos’altro potrebbe aggiungere a proposito?
Oggi, il progetto di conservazione dei paesaggi archeologici sta vivendo una fase di rinnovamento, grazie a un approccio sempre più multidisciplinare che integra aspetti biologici, culturali e gestionali. Questo cambiamento ha portato a una visione più dinamica, che tiene conto della dimensione temporale e della necessità di gestire il processo di conservazione in modo continuo. La conservazione attiva di questi paesaggi richiede una visione olistica e critica, che vada oltre la semplice preservazione dei monumenti e consideri le interazioni tra gli elementi naturali e artificiali. Come detto all’inizio, citando il pensiero di Giacomo Boni, il nodo della questione è il tema della cura. Una conservazione preventiva e programmata della componente costruita, cioè i ruderi, che accetta la sedimentazione dei segni del tempo. Una cura della componente vegetale che è manutenzione e che ne accetta lo stagionale mutamento.


Professor Ugolini, la ringrazio di avere illustrato in maniera così esaustiva la complessità del tema della conservazione dei luoghi archeologici. Ho l’impressione che la coscienza di questa complessità sfugga non solo alla gente comune, ma anche a molti addetti ai lavori. Spero quindi che anche questa nostra breve conversazione possa spronare chi ci legge ad approfondire l’argomento. Prima di salutarci, però, le domando se vuole concludere precisando ulteriormente le motivazioni che vi hanno spinto a scrivere questo volume e gli obiettivi che vi siete dati.
Nel nostro volume, abbiamo inteso definire un nuovo luogo culturale e scientifico, dedicato al progetto e alla conservazione attiva e “inventiva” degli spazi aperti archeologici, dove il progetto non sia ridotto a un corollario di semplici indicazioni gestionali o di convenzionali considerazioni estetiche, ma sia invece supportato da una ricerca che speriamo sia di spessore. Abbiamo inteso realizzare una prima serie di esplorazioni, senz’altro perfettibili e non esaustive, con l’idea di rivolgerci innanzitutto alle diverse figure chiamate in prima persona a confrontarsi con queste problematiche: restauratori, architetti, paesaggisti e archeologi. Lo abbiamo fatto convinti della necessità di visioni progettuali nuove e condivise per far fronte alla inevitabile complessità di queste realtà, col preciso intento di far comprendere reciprocamente i diversi modi di pensare e di agire. Abbiamo cercato di analizzare le peculiarità e le relazioni del sistema archeologico con ciò che lo circonda, soprattutto in termini paesaggistici, come pure i rischi ambientali e antropici a cui è sottoposto e, in ultimo, la difficoltà di interpretarne la complessità.■
Tessa Matteini ha sviluppato un percorso di ricerca specifico nell’ambito disciplinare dell’architettura del paesaggio, legato al progetto di parchi e spazi aperti archeologici e alla conservazione attiva/inventiva di giardini e parchi storici. È architetto, paesaggista, PhD in Progettazione paesaggistica, Professore associato di Architettura del Paesaggio presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Coordina il Master postlaurea in Progettazione paesaggistica e dirige UNISCAPE (rete europea di Università per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio). Autrice di saggi, contributi e monografie, nel 2017 ha pubblicato, sempre per Il Poligrafo, il Manuale di coltivazione pratica e poetica. Per la cura dei luoghi storici e archeologici nel Mediterraneo.
Andrea Ugolini si occupa di conservazione del patrimonio culturale con particolare riferimento ai manufatti allo stato di rudere, a siti e parchi archeologici e a luoghi della memoria del Novecento. È architetto e Professore associato di Restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna. Ha redatto piani di manutenzione/conservazione preventiva e programmata su contesti antichi per il Ministero della Cultura e svolto ricerche sul microclima outdoor indagando i rapporti tra struttura vegetale e contesto archeologico, ha partecipato a campagne di scavo in Italia e all’estero, progettato e diretto cantieri di restauro architettonico e archeologico. Collabora a progetti europei di ricerca, è autore di articoli, contributi in volumi, curatele e monografie.
tra quelli più cercati